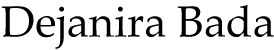Il silenzio di ieri
CTL Editore Livorno
Anno di pubblicazione: 2017 Koi press | 2021 CTL Editore Livorno
Virginia ha poco più di quarant’anni quando suo marito muore all’improvviso. Dopo il funerale inizia a scrivere un diario per superare il dolore. Scrive quello che prova, che sente, e lo scrive rivolgendosi a lui, come se fosse ancora presente, raccontandogli cose che lui sa già, cose che non gli ha mai confessato prima…
DISPONIBILE IN LIBRERIA E ONLINE
ESTRATTO DAL ROMANZO
Milano, 28/10/2013
L’ultima immagine che ho di te è di quando ormai eri sul letto d’ospedale attaccato all’ossigeno e a una siringa enorme che ti somministrava antidolorifici. La stanza aveva le finestre sempre chiuse, assaporava l’aria raramente, soltanto quando qualcuno ne usciva per non fare più ritorno.
Non ti ho voluto portare all’hospice, non ti ho voluto neanche tenere a casa; non ce la facevo a vederti così tutti i giorni, ma passavo a trovarti il più possibile, durante il turno di lavoro e appena staccavo. La notte, però, tornavo a casa a dormire. Perdonami. Dovevo essere lucida anche per i miei pazienti, tu mi avresti capito, avresti accettato. Mi sembrava inutile, tempo sprecato, restarti lì accanto, ventiquattr’ore al giorno, a guardarti respirare a fatica e non potere fare niente, non poterti operare, aiutare, salvare, almeno provarci. Era troppo dura, anche per una come me, questa è la verità.
Aprivi gli occhi, neanche mi riconoscevi, a volte mi concedevi un sorriso, poi gli occhi ti si ribaltavano all’indietro, e li richiudevi. Cominciavi a russare, sembrava che il respiro ti si sarebbe fermato da un momento all’altro. E invece no, sei andato avanti per giorni. Passavo a trovarti, ti stringevo la mano ma neanche te ne accorgevi, non avevi le forze e la capacità di tenermi neanche un dito. Stavi a bocca aperta, senza lenzuolo, e muovevi i piedi come per andare chissà dove. Eri completamente drogato. Non ti sei mai drogato in vita tua, e proprio la fine l’hai trascorsa da tossico. Una volta una paziente, davanti a un suo parente moribondo, mi chiese perché gli eroinomani si riducessero così, che senso potesse avere, e io le dissi che lo fanno con lo stesso scopo di un malato terminale, per non sentire il dolore, per non sentire il peso dei pensieri, della sofferenza, della vita. Non cambia nulla. Non c’è molta differenza tra un drogato e un malato terminale che usa cure palliative. Entrambi stanno lì ad aspettare che la vita finisca e che con essa termini anche il tormento che spesso comporta.
Per raggiungere la tua stanza dovevo prendere l’ascensore. Chiusa lì dentro per un paio di piani cercavo di prepararmi psicologicamente, -anche se era inutile- e poi dovevo passare per un lungo corridoio che mi ha sempre fatto pensare al miglio verde. Non finiva mai quel corridoio pieno di stanze con dentro altri malati, che almeno erano anziani, molto anziani. Sembravano già delle mummie ingiallite, e tu cominciavi ad assomigliargli. Erano stesi a letto, degli zombie con i parenti attorno intenti a chiacchierare come al bar in attesa del caffè; anziani, bambini, giovani, tutti lì, in piedi o seduti, ad aspettare. Scappava anche qualche sorriso.
Anch’io un giorno venni da te cercando di fare una battuta. Riprendesti coscienza per qualche secondo e ti chiesi: “Quanti sono questi?”, facendo con le dita delle mani il numero tre, sorridendoti. Poi chiudesti gli occhi. Non lo avrei mai fatto se avessi saputo che quella era l’ultima volta che mi avresti visto. L’ultima immagine che hai avuto di me, sono io che ti chiedo ironicamente “quanti sono questi”. Non è buffo? Chissà se lo hai visto quel tre, chissà se hai capito che ero io. Hai richiuso gli occhi per sempre per non vedere mai più la mia faccia da stronza e il mio cinismo, vero? Ma lo sai che è e sarà sempre la mia unica arma di difesa. Senza il cinismo, non avrei mai potuto fare questo lavoro. Quel tre lo feci per farti sorridere, scherzavamo sempre, noi. Ma forse non era il momento. Solo qualche mese prima mi avresti risposto sorridendo: “cinque?”. L’ho visto che stavi per rispondere, che volevi farlo. Avevi anche un sorriso beato stampato in faccia. Non hai fatto in tempo. Non ti preoccupare, so che lo hai visto quel tre, che hai visto i miei occhi, e che il tuo sorriso è stato appannato e i tuoi occhi si sono chiusi solo per quei maledetti antidolorifici.
A noi bastava uno sguardo per capirci. Eravamo una di quelle coppie che si leggevano nel pensiero, che non avevano neanche bisogno di fare una domanda per ricevere una risposta. Completavamo le frasi l’uno dell’altra. Eravamo così, eravamo noi. Quel “tre” lo feci soltanto per vedere se eri davvero cosciente. Mi dissero anche che aprivi gli occhi solo quando sentivi la mia voce.
Poi ti accarezzai il volto, ti presi la mano, e ti diedi un bacio sulla guancia, convinta che ti avrei rivisto sveglio, anche solo per un secondo, in quell’ultimo classico scampolo di energia che travolge il morente poco prima che se ne vada per sempre. Invece no, tu di energia, di vita, non ne avevi proprio più. Avevi dato tutto, e ti lasciai lì a dormire, a russare, a scalciare come un cane quando sogna di correre libero su un prato.
Però ci sono sempre stata al tuo fianco, anche quando ormai ti pisciavi addosso, a casa. Pensavi che non lo sapessi, quando succedeva c’era sempre l’infermiera a pulirti, ma una volta ti vidi, quando la porta della camera rimase socchiusa. Vidi l’infermiera farti alzare dal letto e metterti a sedere sulla poltrona mentre ti cambiava le lenzuola. Ti vidi anche piangere quella volta. Era troppo anche per uno come te, troppo umiliante e avvilente. Sei sempre stato orgoglioso, fino all’ultimo, e non credo che tu abbia desiderato neanche una volta di suicidarti, nonostante non ne potessi più. Di vomitare avevi smesso da un pezzo, da quando non andavi più in ospedale per la terapia, che ormai era inutile. Eri così tranquillo anche mentre facevi la chemio, ti mettevi seduto sulla tua poltrona, con la flebo attaccata al braccio, a leggere il tuo libro, e stavi lì, per ore, attorniato da altre persone che si comportavano come fossero sul tram, al bar; qualcuno mangiava, qualcuno con il cellulare in mano, qualcuno guardava il vuoto dritto davanti a sé, e aspettavate, cercando di non pensare al futuro, vivendo il momento come persone normali e sane, sperando. Conoscevi tutti i pazienti ormai, ed eri stupito della quantità di giovani che ti circondavano, donne e uomini della tua età, ma anche trentenni, ventenni. Ti dissi che c’erano pochi anziani perché tanti di loro che avevano il cancro non erano più curabili, non ci si provava neanche a operarli o a fargli iniziare delle terapie. Le infermiere erano le tue preferite, un paio erano diventate tue intime amiche, così come una volontaria, Angela, che si occupava solo di ascoltare persone come te. Chissà quante cose le avrai confidato, cose che non osavi dire neanche a me, cose di cui avevi paura, o forse parlavate del più e del meno, di che tempo faceva fuori. A volte arrivavo e vi trovavo a ridere, e non mi dicevate mai perché stavate ridendo. Un’altra volta vi avevo colto mano nella mano. Angela era commossa, tu no. Appena mi avvicinai Angela si alzò e non mi dicesti niente neanche in quell’occasione. Ma non ero gelosa, avevo capito che in quella stanza si era andato a creare un mondo che non mi comprendeva già più, e forse era meglio così. Allora ti lasciavo con un sorriso al tuo mondo, alle tue nuove donne, amiche, compagne, e con la mascherina ancora appesa al collo, la cuffietta, il mio bel camice verde, me ne tornavo alla solitudine dei miei corridoi, sciabattando, con lo sguardo perso.
In quel periodo però, quando tornavi a casa, dopo un po’ cominciavi a stare male, andavi in bagno, ti mettevi a terra, abbracciavi il water, con le gambe piegate da un lato, come spezzate; e quando venivo a sorreggerti la testa per aiutarti, mi cacciavi via per la vergogna. Solo quando vomitavi al lato del letto o del divano, perché non riuscivi neanche ad arrivare al bagno, mi permettevi di starti vicino, di tenerti una mano sulla fronte madida di un sudore freddo e acre. Perché questo fa l’amore, ti fa sorreggere fronti madide di sudore freddo e acre senza provare ribrezzo. Ti fa amare un uomo dalla faccia gialla e incartapecorita, dalle occhiaie viola e infossate; ti fa accarezzare la sua testa senza capelli, una testa di adulto che sembra tornato bambino, e che invece sta morendo. Ti fa amare un uomo anche quando ti vomita sulla mano che tiene la bacinella, quando espelle solo acqua, male, e quella bile che brucia l’esofago, la gola, il cuore, e che fa emettere grida di dolore che non pensavo un umano potesse emettere.
Sotto quella coperta di pelliccia che c’eravamo comprati in un giorno di follia invernale tanti anni prima, e che ti sommergeva, sembravi così piccolo. Ti ci si perdeva lì sotto, magro com’eri. Eri così dolce, così inerme e fragile, anche quando la cacciavi via con apparente forza nei tuoi momenti confusionali. Avrei voluto inglobarti in me. E non restavi mai in pigiama, ti andavi a vestire lo stesso la mattina, e ti lavavi, almeno tentavi. Ma li sentivo gli sforzi che facevi, sembrava che stessi scalando una montagna, ma neanche lì volevi il mio aiuto. Uscivi dal bagno e ti davi una parvenza di uomo sano e dignitoso. Ma durava poco. Stavi in piedi cinque minuti e ti rimettevi a letto o sotto il guanaco che tenevamo sul divano, ma guai a toglierti quell’ultimo scampolo di decenza. Poi smettesti anche di vestirti e rimanesti in pigiama fino alla fine. I vestiti te li rimisero solo nella bara. Ti ho fatto mettere il tuo abito grigio preferito, stai tranquillo, anche se ti stava un po’ largo, ma forse lo sai.
La prima volta che mi chiamarono, -perché era quasi arrivato il momento- ricordo che mi precipitai all’ospedale, e appena prima di entrare vidi una donna ferma al semaforo. Stava piangendo tanto. Chissà quale orribile notizia aveva appena ricevuto. Era sola. Chissà quanta gente si sarà ritrovata a piangere proprio a quel semaforo davanti all’ospedale anche per notizie che avevo dato io stessa. Era il semaforo del pianto, quello. C’erano dei buchi sull’asfalto del marciapiede, forse causati dalle migliaia di lacrime cadute in quel punto.
Poi diventò verde, e la donna mi passò di fianco, ancora piangendo, e io ti raggiunsi per ricevere la mia di notizia.
Sì, era arrivato il momento. Non avvenne come quando ti ricoverarono per un piccolo angioma cavernoso qualche anno prima, per il quale dovettero anche operarti al cervello. Quella volta mi chiamarono, corsi da te, e ti trovai in corridoio con delle cuffie alle orecchie e la sigaretta elettronica che avevi comprato da poco per cercare di smettere di fumare la pipa. Ti guardai, e quasi sbigottita ti dissi:
– Non mi sembra che tu stia così male.
– Non puoi immaginare quanto mi stia rompendo. E il bello è che non mi dicono niente! Sto aspettando ancora il risultato della tac che mi ha fatto il tuo Marchetti, che a quanto pare si è volatilizzato. Vieni trattato peggio quando ti conoscono, altroché.
– Vuoi che lo chiami?
– No, lascia stare, arriverà.
– Come ti senti?
– Bene. Mi sono solo spaventato, tutto qui.
Eri nel tuo studio, e a un certo punto ti si era bloccata la gamba destra. Ti spaventasti molto. Riuscisti a chiamare subito l’ambulanza, e ti facesti portare nel mio ospedale.
Quella volta, finito l’orario delle visite, uscii e non piansi, sapevo di cosa si trattava e che c’erano poche probabilità che le cose andassero male.
Solo il giorno in cui mi dissero che era davvero finita, contribuii anch’io ad aumentare i buchi sull’asfalto a quel semaforo. Le lacrime non scesero fino all’esatto momento in cui mi trovai lì. La regola valeva per tutti.
Da quel momento non versai più una lacrima. Sparirono. Le lasciai tutte lì, a quel semaforo, su quel marciapiede.
Non rividi mai più la tua faccia. Non me la sentii neanche di venire nella camera mortuaria, mi dispiace, non ce la feci proprio, mandai Marco a riconoscerti per permettere a quelli delle onoranze di chiudere la bara. Volevo ricordare il tuo viso e il tuo corpo ancora caldo, e non la tua faccia fredda e indurita, perché so che se ti avessi visto così mi sarebbe rimasta impressa solo quella d’immagine, per sempre.
Incontrai soltanto la bara chiusa con dentro il tuo corpo. Una bara semplice, di legno. I tuoi amici la portarono fuori dalla cappella dopo il funerale, e il sole t’inghiottì, e t’accompagnò fin sotto terra. Era una bellissima giornata, splendida. Volesti una tomba sotto terra perché odiavi quei loculi di cemento incastonati su per quei muri così affollati. Tu volevi la pace, la quiete, la natura, il contatto con l’erba e i suoi odori. Lì, volevi andare. E il suolo ti prese con sé come suo eterno marito.