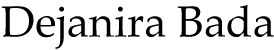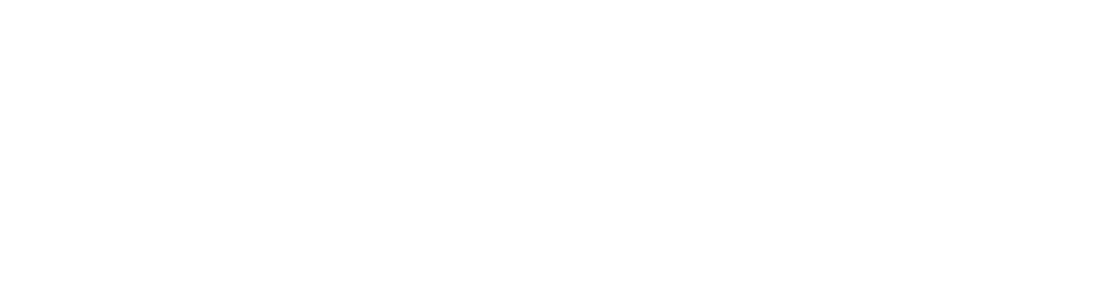20.000 Days on Earth, la recensione del film
Nick Cave è troppo poco famoso. È strano. Anzi, in fondo, pensandoci bene, non è affatto strano che un artista del genere non sia amato, apprezzato, osannato da tutti, ma propri tutti. Nick è un outsider, lo è sempre stato, e la sua musica non è per tutti. Le nostre madri è difficile che lo abbiano mai ascoltato, che lo apprezzino o che addirittura lo conoscano! Forse qualcuno dei nostri padri, più possibile dei nostri amici. Nick non è David Bowie, non è una Pop Star, non lo è mai stata, ma per alcuni è una Star. Eppure Nick ci teneva a diventare famoso, a essere ricordato per sempre, tanto da scrivere nel suo testamento -spuntato da dei fantomatici archivi appositamente allestiti a Brighton per il film, ma con materiale vero recuperato dalla Nick Cave Collection all’Arts Centre a Melbourne, insieme a foto di Nick bambino, Nick ragazzo, della moglie e degli amici- di voler lasciare tutti i suoi averi al Memorial Museum a lui intestato. Nick Cave è un poeta, un intellettuale, uno scrittore, un cantante, un cantautore, un musicista, ma anche un uomo normale, che si sveglia presto per lavorare, per scrivere, cui piace stare chiuso nel suo studio, nel suo mondo, e che non vede l’ora di tornarci, costretto anche lui a uscire e avere contatti con la realtà, con i collaboratori, gli amici, i figli, la moglie da tormentare, parole sue. Mangia, dorme, si lava, si veste, guarda la tv, combatte draghi.
Ma Nick Cave non è per tutti.
Nick è sempre stato un po’ di nicchia in fondo, se pensiamo al successo che altri rocker hanno avuto. È un artista impegnato che a un concerto, se non lo ami alla follia e non sei un suo forte estimatore, ti può far pure annoiare o sbadigliare, o forse ti trovi a sbadigliare perché l’angoscia delle sue performances ti toglie l’ossigeno.
Nick Cave non è per tutti.
Nick Cave piace alla gente di una certa età, che legge certe cose, che ascolta certe cose. Piace ai giovani, ma a certi giovani, a quel tipo di giovani che si drogano, che sono dei darkettoni e che magari manco erano nati quando Nick faceva già musica negli anni ’80. Nick Cave è per gli alienati, per i tossici, i persi, i diversi, per gli intelligenti, e non tutti lo sono, e per fortuna. Se no sai che noia! Eppure quello che stupisce di questo documentario… no, scusate, perché un documentario non è, è più un film… no, neanche, una biografia… no, non ci siamo… è… un’opera d’arte fatta da due registi che infatti vengono dal mondo dell’arte, non del cinema, non della musica: Iain Forsyth e Jane Pollard. Comunque, dicevamo, quello che stupisce è che Nick risulta anche simpatico, ironico, divertente. Le risate in sala si sprecavano, ma senza nulla togliere all’intensità, alla drammaticità, alla profondità di questo film/non film. Una storia nella storia. Realtà che s’incontra con finzione. Infatti ci ha lavorato anche Jonathan Amos, l’editore, che ha prestato il suo talento alle commedie inglesi Peep Show e Pramface per la TV, Attack The Block e Scott Pilgrim Vs The World, che infatti ha apprezzato il taglio ironico dei due registi. Fantastica la battuta di Warren Ellis, storico collaboratore di Cave nei Bad Seeds, che durante una scena nello studio di registrazione (vero o immaginario? Chi lo sa ma che importa?) mentre cerca di far cantare a dei bambini una parte della canzone Push the Sky Away, dopo aver ricevuto da tutti i complimenti per aver fatto da ottimo direttore del coro a questi bimbi dice una cosa tipo: “Eh sì, infatti, questo doveva essere all’inizio, anzi, la prima cosa che volevo fare, ma poi sono arrivate l’eroina e l’alcol e gestire tre professioni non era possibile.”
Nick Cave non è per tutti, no.
Questo documentario, scusate, questo non film, è un capolavoro, c’è poco da dire, una pellicola con i controcazzi. Qui si parla di morte, di paura, di paura di vivere, d’invecchiare, di esistere, di trasformazione e cambiamenti, di religione, non ci sono mica solo le battute. La potenza di questa pellicola è travolgente e la scusa dell’intervista da parte di un vero psicanalista, Darian Leader, che analizza Cave per farlo parlare e fargli raccontare di sé, è semplicemente geniale. E poi aneddoti, come quello sul live di Nina Simone, ricordi e ricordi, del padre, della madre, del suo passato da tossico, di Nick da giovane, dei figli, della moglie, cui fa la dichiarazione d’amore più bella che una donna possa immaginare. Il giorno in cui la vide per la prima volta, tutti i suoi sogni erotici da ragazzo, da adulto, svanirono e ci fu solo lei, per sempre. E poi gli incontri con i fantasmi, i personaggi e le persone che sono gravitati come satelliti intorno alla vita di Cave, e che qui compaiono nella sua mente, nella sua psiche più profonda, come un flusso di coscienza che prende vita e si materializza dentro un’automobile. Ed ecco arrivare l’attore Ray Winstone, che comparve nel film The Proposition scritto da Cave con la regia di John Hillcoat, con cui affronta il tema della mezza età, della paura di vivere, dell’impossibilità di cambiare, di evolversi, di diventare qualcun altro, di essere sempre entusiasti di stare su un palco. E poi lui, Blixa Bargeld, che non ha bisogno di presentazioni, cui Cave chiede finalmente, a distanza di anni, perché se ne sia andato così d’improvviso nel 2003. Si chiariscono lì, in quella macchina, mentre Cave è alla guida. Kylie Minogue, seduta dietro, come un’ombra, che scambia sguardi con il suo amato Nick solo tramite lo specchio retrovisore. I due parlano del successo, della fama, del fatto che la Minogue, prima della loro collaborazione, non lo avesse mai sentito nominare, che si era dovuta leggere una biografia. I registi non avevano avvisato Nick Cave di questa cosa, glieli hanno piazzati in auto e con alcuni Cave non si vedeva né sentiva davvero da anni, per rendere ancora il tutto più realistico, e hanno terminato le riprese solo quando la conversazione andava a esaurirsi in maniera naturale. E l’imbarazzo, l’emozione, si percepisce, si respira.
Il tutto accompagnato da una colonna sonora strepitosa, di vecchi ma anche di nuovi brani, come Give Us A Kiss e Jubilee Street. La “sceneggiatura”, invece, se così si può chiamare, è stata scritta in parte dai registi ma principalmente è stata tratta dai taccuini di Cave e da brevi testi scritti da Cave appositamente su argomenti suggeriti da Pollard e Forsyth, montati per formare la voce narrante del “film”, che per fortuna è sottotitolato e non doppiato. Ci mancava solo di sentire uno dei nostrani italici doppiatori coprire la voce da brivido di Nick!
Una sensazionale vita quella di Cave, perché se esci vivo dalla droga ne hai di cose da raccontare. Se vivi davvero, ne hai eccome di storie da condividere. Se poi si aggiunge una vita del genere a un’immaginazione e a un’intelligenza senza paragoni, il risultato è che il 20.000° giorno sulla terra risulta il più bello e il più interessante del mondo. Un giorno preso a caso, mezzo inventato e mezzo no, diventa un’opera d’arte, un film d’autore. Una giornata sola, un po’ quella di Bloom nell’Ulisse di Joyce. Un film/non film, a questo punto chiamatelo come vi pare, che anche chi non ha mai sentito nominare Nick Cave prima d’ora dovrebbe vedere, e questa è la cosa importante, forse la più importante e che ne decreta il successo e che dovrebbe rendere fiero chiunque vi abbia collaborato.
No, ma forse 20.000 Days on Earth non è per tutti, come non lo è Nick Cave.
E non è snobismo, sia chiaro. Ascoltare Nick Cave e vedere 20.000 Days on Earth per credere, per provare, per provare a capire un artista che è troppo poco osannato e celebrato nel mondo. Forse lo sarà di più una volta morto, quando sarà troppo tardi…
Meno male che è arrivato 20.000 Days on Earth a ricordarlo, a ricordarcelo, a ricordarvelo, mentre Nick è ancora qui, vivo e vegeto tra noi, in tutta la sua tracotante grandezza e genialità. Per il Memorial Museum aspetteremo ancora un po’.
Da Jaymag.it