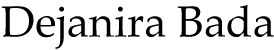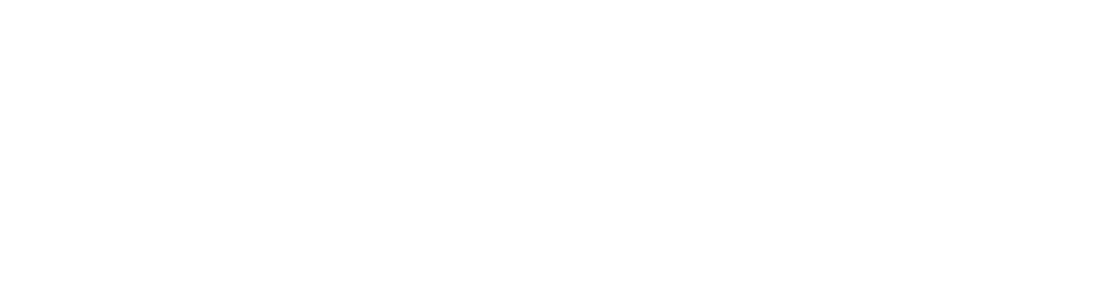La morte non esiste. Intraprendere la via del distacco nelle Catacombe dei Cappuccini
Appena arrivata a Palermo, la prima cosa che ho fatto non è stata bermi una spremuta d’arancia, mangiarmi un cannolo, andare a Ballarò, visitare la cattedrale. No, la prima cosa che ho fatto è andare a vedere le storiche mummie della città nelle Catacombe dei Cappuccini, luogo che sembra rappresentare il cerchio della vita, e che in passato è stato visitato durante il Grand Tour anche da Maupassant, De Sade, Alexandre Dumas e tanti altri.
Furono i frati Cappuccini a dare vita a questo luogo di sepoltura alla fine del 1500, sotto alla chiesa di Santa Maria della Pace. All’inizio si trattava di una specie di fossa comune, come precisato nel libro La veglia eterna. Catacombe dei Cappuccini di Palermo (Logos, 2014), e solamente i frati erano ammessi. Ma un bel giorno, quando si decise d’iniziare a scavare per creare le catacombe, fu aperta la fossa comune, e molti dei frati buttati dentro alla rinfusa uno sopra all’altro furono trovati ancora integri. Si gridò al miracolo e si scelse di esporli. Ed ecco che anche i laici cominciarono a fare a gara per essere sepolti in quel luogo. Si dovrà aspettare il 1783 per accogliere chiunque ne facesse richiesta, prima gratuitamente, poi con delle offerte e poi con delle tariffe ben definite. Le Catacombe dei Cappuccini erano talmente famose e importanti, che non venivano interrotte le sepolture nemmeno durante le epidemie.
Perché il cerchio della vita? Perché quando scendi le scale delle Catacombe sei come un bambino. Sei pieno di gioia, di stupore, di curiosità. Guardi le mummie della galleria degli uomini, tutti vestiti per bene, con quei tessuti ancora intatti, quei baffi e quei capelli che spuntano dal cranio. Gente che ha desiderato ardentemente farsi mettere lì, appesa o sdraiata, per farsi ammirare e accudire dai propri cari per l’eternità.
Poi, poco prima di arrivare nella galleria dalle donne, le emozioni si fanno contrastanti. I corpi sono tanti, alcuni sono deformi, sono potenti, anche se sono morti, anzi, lo sono proprio perché morti, e giacciono lì, di fronte a te.
E allora ecco la tristezza, l’angoscia, lo sgomento, forse pure un po’ di nausea. C’è anche una nicchia dedicata alle vergini.
Ma ecco arrivare la galleria delle famiglie. Donne e uomini si sono uniti, hanno dato vita a dei bambini, morti anche loro, tra cui la famosa mummia più bella del mondo, “La bella addormentata”, la piccola Rosalia Lombardo, di appena due anni, morta di broncopolmonite nel 1920 – l’ultima arrivata, e accolta in via eccezionale, perché il cimitero chiuse nel 1880 – che è fin troppo bella, perfetta, intatta, troppo viva, quindi, in realtà, meno interessante.
E le emozioni cambiano di nuovo mentre procedi, succede di tutto, come nel corso della vita, e sorridi a tuo marito che ti cammina a fianco e scambi due chiacchiere. E arrivi nella galleria dei professionisti, perché la vita è lavoro, c’è poco da fare. E chiedo a mio marito un po’ d’acqua dallo zaino. Poi mi giro e chiedo a una mummia “Ne vuoi un po’?” e non mi sembra di fare nulla di strano, perché sono lì, presenti, più vivi dei vivi, ed è questo che avrebbero voluto.
Proseguo, poi mi fermo improvvisamente a metà della galleria dei professionisti, mi si illuminano gli occhi; è proprio lui, il mitico colatoio o putridarium. Finalmente ne vedo uno dal vero! Sono felice come una bambina al luna park. Purtroppo è chiuso al pubblico ma dalla grata si vedono ancora benissimo. Si vedono ancora i corpi dei cadaveri stesi (si potevano mettere anche seduti) sopra a questi sedili di pietra con un buco in mezzo, una sorta di tazza del cesso dove far colare tutti gli organi e i liquami, il proprio putridume, per poi poter procedere con la mummificazione. Una volta fatto scolare tutto per bene, i corpi venivano portati fuori e fatti seccare, e poi riempiti di paglia nei punti giusti – se per esempio mancava qualche pezzo o c’era qualche parte scheletrica di troppo – e poi vestiti e riposti nelle nicchie, come bambolotti pronti da vendere.
Si pensi che nel famoso putridarium di Ischia, quello delle suore dell’Ordine delle Clarisse, le sorelle decedute venivano fatte sedere rannicchiate sui colatoi, e le sorelle vive si sedevano in mezzo alla stanza per meditare sulla morte. Se ne stavano lì, a osservarle decomporsi davanti ai loro occhi, a meditare sul non attaccamento, e poco tempo dopo ci finivano pure loro su quei sedili: infatti, stare chiuse in quella stanza senza finestre, respirando quel miasma emanato dai cadaveri, le faceva ammalare e poi morire.
Arrivi nell’ultima galleria, quella dei frati, la via della contemplazione è presa. Puoi non aspettarti nulla dopo la morte, oppure avere fede, e cioè credere che quel nulla sia Dio. Alla fine s’intraprende la via del distacco, l’unica via giusta e possibile, come insegnarono anche il Buddha e Meister Eckhart, quell’ateo spirituale che ho preso ad amare alla follia: “Dio è morto, perché io muoia al mondo e a tutte le cose create”.
Rimango sola, in silenzio. Sono a braccia incrociate, testa inclinata, mi guardo attorno, mi giro, e poco più in alto, di fronte a frate Silvestro Da Gubbio, il primo inumato, il 16 ottobre del 1599, ci sono io allo specchio. Io e una mummia siamo nella stessa posizione. Ci guardiamo, o meglio, io fisso le sue orbite, perché ormai è solo un teschio, ma mi guarda, ne sono certa, e con quelle braccia incrociate e la testa un po’ inclinata ci diciamo “Visto? È tutto qui”. In fondo, perché avere paura? Di cosa? Se c’è la morte non ci sono io. Se ci sono io, vuol dire che la morte non c’è. La morte riguarda i morti e non i vivi. La morte è come un pensiero, mica è un fatto, passa e se ne va e non è mai stata concreta. L’unico modo per smettere di avere paura è familiarizzare con la morte, smettere di negarla e nasconderla. Ma non lo vogliamo capire.
Il cerchio si chiude, la visita è conclusa.
La morte non esiste.