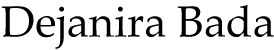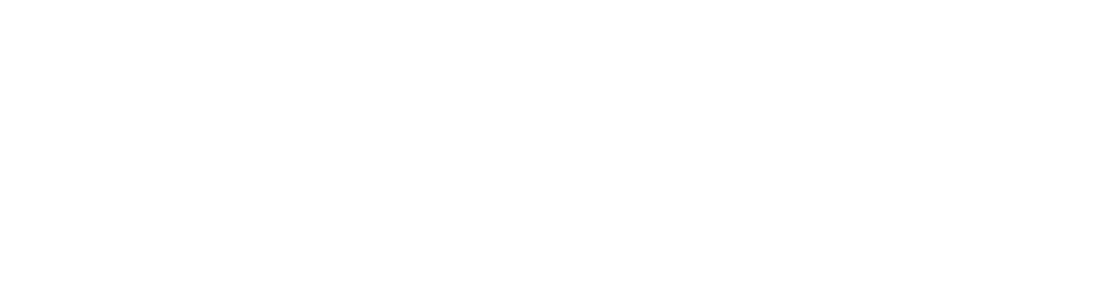Dove l’essere umano non ha mai messo piede. Viaggiamo perché non possiamo farne a meno e le foreste hanno una magnificenza più profonda di un monumento. “Into the Okavango”, un capolavoro
“Sono convinto che esistano al mondo persone nate in una patria che non è la loro e che soffrono di nostalgia per una terra che non hanno conosciuto. La casa dove vissero bambini, le strade dove giocarono, non hanno fascino per loro. Forse si tratta di un bizzarro fenomeno di atavismo che spinge alcuni individui, pellegrini erranti, verso i luoghi che i loro antenati abitarono secoli e secoli prima”,
Aldous Huxley
Perché l’uomo viaggia?
Come mai la chiusura dei confini è stata un’enorme limitazione alla libertà che non si può liquidare con “L’Italia è il paese più bello del mondo, che ci frega di andare all’estero”? Il viaggiatore non è un turista, c’è una spinta, un’indole innata che porta l’essere umano ad andare alla scoperta di qualcosa di nuovo fin dall’inizio dei tempi. L’uomo è un esploratore, e prova ne è che non gli basta la Terra, vuole arrivare nello spazio, e ci è arrivato, e s’inoltrerà fino su Marte prima di quanto pensiamo, anche grazie allo storico lancio di SpaceX dei giorni scorsi.
Ma restando dentro i confini terrestri, basta guardare il film pluripremiato Into the Okavango: l’ultimo paradiso, per assaporare cosa porta l’uomo a viaggiare.
Mi spiace, ma l’Italia non è l’unico bel paese del mondo. È bello, nessuno lo mette in dubbio, ma ci sono paesaggi, ecosistemi, territori che toccano le vette del sublime, e che l’Italia non ha e non può avere perché non ha l’immensità e la maestosità per esempio dell’Africa e neanche dell’America e dei deserti del mondo arabo. E soprattutto, il turismo in Italia è un turismo spesso antropocentrico. Si viene in Italia anche per il suo mare e le sue montagne e campagne, certo, ma soprattutto per l’arte, i monumenti, che ci ricordano la grandezza dell’uomo, ma ne determinano anche i limiti nel confronto con la magnificenza della natura. L’uomo, con i suoi monumenti, le sue chiese, i suoi monasteri, prova da sempre a imitare e raggiungere il divino, a cercare risposte, ma spesso è quando arriviamo in paesaggi incontaminati, sulle cime delle montagne, nelle savane o ancor più nei deserti, dove per alcuni apparentemente “non c’è nulla da vedere”, che i viaggiatori o gli eremiti trovano quel contatto con un possibile creatore o con il vuoto, con quel tutto o nulla da cui veniamo, che potrà essere anche frutto del caso, chi lo sa, ma questo non toglie fascino al mistero.
Il film Into the Okavango: l’ultimo paradiso ci pone di fronte ai grandi dilemmi dell’esistenza ma è come se ci aiutasse a trovare anche delle risposte: siamo qui, non sappiamo come e perché, né da dove veniamo, né se qualcuno o qualcosa ci ha creato, ma quello che possiamo fare è essere grati di tanta bellezza e non smettere mai di cercare, di esplorare, di conoscere, d’imparare.
Into the Okavango è un documentario avvincente del National Geographic, acclamato dalla critica, uscito nel 2018 – visibile su Disney Plus, Amazon e altri canali – scritto, diretto e prodotto dal regista Neil Gelinas, con musiche toccanti del compositore di colonne sonore Sven Faulconer, decisamente influenzato dai Sigur Ros. Non è un documentario solo naturalistico ma è soprattutto una storia: un gruppo di esploratori – capitanati dal sudafricano Steve Boyes, biologo della conservazione – decide di recarsi alla foce dell’Okavango, in Angola, una zona denominata ‘il buco nero’, e navigare il fiume Cuito per quattro mesi su canoe scavate nel legno, per scoprire lo stato di salute dell’Okavango, attraverso Angola, Namibia e Botswana. Nessuno è mai stato da quelle parti, anche a causa della guerra e delle mine antiuomo ancora molto presenti in Angola.
Steve è in compagnia di altre persone, tra cui Maans Booysen, Paul Skelton, Bill Branch, Gotz Neef, Tumeletso Setlabosha, detto ‘Water’, amico di Steve, nato in Botswana, nel cuore del Delta dell’Okavango (Patrimonio dell’Unesco), appartenente alla tribù ba’Yei, e Adjany Costa, giovane biologa che oggi è ministro dell’Ambiente, del Turismo e della Cultura del suo paese, l’Angola.
Adjany, all’inizio del film, racconta quanto sia stato difficile crescere in un paese in guerra e ci dà subito un grande insegnamento: imparare a vivere il momento presente e non guardare troppo al futuro né al passato, perché come la guerra insegna, ogni momento potrebbe essere l’ultimo e quindi non bisognerebbe fare progetti a lungo termine. Come dice lei stessa: “Sei vivo adesso? Puoi guadagnare dei soldi? Riesci a mantenerti? Puoi fare dei figli? Quindi fallo adesso”, perché in fondo non possiamo avere il controllo su nulla. Dobbiamo imparare a vivere il qui e ora per avere una vita quantomeno soddisfacente.
Ma perché questi giovani esploratori intraprendono un simile viaggio? Se lo chiedono anche loro durante le riprese, soprattutto all’inizio, quando scoprono che la parte iniziale del fiume Cuito ‘non esiste’, non è navigabile, perché ricoperto da un fitto strato di torba che ha l’effetto di una spugna, e per dieci giorni sono costretti a trascinare queste canoe di quasi 400 chili. Non sanno se l’acqua comparirà di nuovo e quando lo farà, ma non si arrendono. Vivono dei momenti difficili, Adjany si chiede davvero chi glielo ha fatto fare, e la risposta è perché sì, perché il desiderio di scoperta è più forte, perché nessuno lo ha mai fatto prima, perché si trovano in luoghi dove l’essere umano non ha mai messo piede e questo non solo è eccitante ma dà un senso all’esistenza. E allora si lasciano a casa i figli, non ci si lava, si dorme in tenda per mesi, si mangia riso e piselli, riso e fagioli, si rischia la vita tra mine antiuomo e ippopotami che ti mordono la canoa, tra incendi che devastano le foreste e che arrivano fino all’acqua ma che sono causati da popolazioni indigene che usano questa tecnica per cacciare, e quindi c’è poco da arrabbiarsi perché è il loro unico sostentamento. Si entra in contatto con popolazioni che non vedevano altri esseri umani da quarant’anni, con bambini, ragazzi e adulti che non sono mai andati a scuola. Si giunge su una riva che odora di morte e si scopre che quella zona è una riserva di caccia piena di pelli e di teste di elefanti uccisi dai turisti, perché lì è legale, si può fare. Ognuno cerca di sopravvivere come può.
Perché viaggiare? Perché fare un viaggio simile? Perché vivere vuol dire anche rischiare di morire. Perché una vita senza rischio è schiavitù. Steve Boyes è una specie di Fitzcarraldo che trasporta una canoa anziché una nave e che ci ricorda che Chi sogna può muovere le montagne.
Into the Okavango: l’ultimo paradiso è un documentario con immagini degne di Terrence Malick, un’impresa che ha permesso di geolocalizzare oltre 30.000 specie naturali, scoprendo 38 specie mai viste prima in Angola e 24 forse mai viste prima dall’uomo. Inoltre il governo angolano ha firmato un impegno di assistenza e, assieme alla Namibia e al Botswana, lavora con il team per creare un’area protetta che comprenda tutte le aeree naturali dell’Okavango. Un documentario che ci ricorda il rispetto che dobbiamo avere nei confronti degli esseri umani, della natura e degli animali e che tutto è interconnesso.
Alla fine Steve dice: “Tutto il mondo è tenuto insieme da legami vitali. Il legame e la diversità sono i due pilastri che mantengono vivo il nostro mondo. Ora abbiamo un pianeta vivente, interconnesso e diversificato, per produrre l’aria che respiriamo e per purificare l’acqua che beviamo. È questo che ci rende diversi. È una caratteristica unica e speciale che ci contraddistingue nel cosmo”.
Un film commovente ed emozionante, che alla fine ti fa piangere nell’esatto istante in cui cominciano a farlo anche Steve e di Adjany, quando capiscono di avercela fatta e che il viaggio purtroppo è terminato. Un film che ti ricorda che non si può mai rinunciare alla libertà, che viaggiare vuol dire anche andare in cerca della propria vera casa e soprattutto di qualcosa per cui valga la pena vivere.
Articolo tratto da Pangea