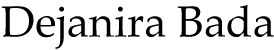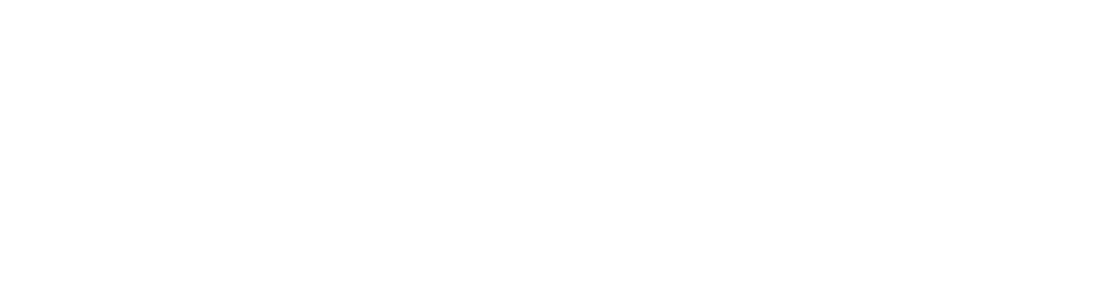L’urlo e il furore. Ecco perché la mostra di Munch a Milano è una delusione
È difficile spiegare perché si ami l’arte. Per me, andare a una mostra, è come fare un pellegrinaggio in un tempio, un cammino spirituale. Mi spinge la stessa motivazione che mi porta ad andare a perdermi nei deserti del mondo. Cerco Dio, forse me stessa. Cerco ciò che non si può descrivere con le parole. Cerco il silenzio, la contemplazione, e certi artisti sembrano aver creato le loro opere proprio per agevolare tutto questo.
Forse ho troppe pretese, forse per me l’arte è quasi una forma sacra di religione, ed è per questo che ho trovato deludente la mostra di Milano Munch. Il grido interiore. In verità, sono anni che le mostre a Palazzo Reale sono deludenti. Sono mostre per chi non frequenta le mostre. Sono forme d’intrattenimento. Sono contentini dati a chi vuole passare un’oretta facendo qualcosa di “culturale”, di diverso, possibilmente per farsi un selfie.
Sia chiaro, vale comunque la pena di andare a vedere Munch a Milano, anche solo per opere come Le ragazze sul ponte, Disperazione del 1894, La morte di Marat (1907), Notte stellata (1922–1924), Malinconia (1900–1901), lo stupefacente Autoritratto tra il letto e l’orologio (1940–43), Vampiro (1895), Autoritratto all’inferno (1903). Anche se prevalgono le opere su carta.
Però una riflessione è d’obbligo. Perché le mostre, in Italia, e soprattutto a Milano, sono sempre così povere e scarse? Perché non si prendono tre piani di Palazzo Reale e non si fa una retrospettiva di Munch degna di questo nome, capace di attirare anche appassionati dall’estero? Non ci sono i soldi? Milano s’accontenta, potrebbe dare e fare molto di più, e invece no, perché tanto c’è la moda, basta e avanza. Una Milano che appena si varca il confine della Svizzera risulta provinciale, perché se la tira come una grande città europea pur non essendolo, e lo si evince anche dalle mostre che propone, specchietto per le allodole sotto a una cappa non solo d’inquinamento ma di superficialità.
Ma tanto lo sappiamo, l’Italia è un paese che pubblica libri per chi non legge libri, musica per chi non ascolta la musica. E allora ecco una mostra di Munch diventare un evento multisensoriale, un luogo dove imporre divertimento ed emozioni, invece di lasciare le persone a contatto con i propri pensieri e sentimenti, al cospetto dell’atrocità della morte. Becere note di piano riecheggiano in almeno due sale, così, senza motivo, senza nessun senso, forse per rendere il tutto conciliante e piacevole. Ma c’è di peggio. Di fianco al dipinto Disperazione c’è un televisore accesso da cui emerge una voce che in loop e ad alto volume spiega delle cose di una banalità imbarazzante sull’Urlo, e con tono divertito, ovviamente insistendo sul risultato d’asta di un pastello venduto a più di cento milioni di dollari, sul fatto che esistano i rotoli di carta igienica con L’Urlo e addirittura una emoji. Inoltre, ci dice anche che le varie versioni dell’Urlo devono essere esposte raramente e su turni, che in realtà suona più come una scusa per dire: “Guardate che tanto qui, L’Urlo che tanto cercate e che siete venuti a vedere per farvi un selfie perché tanto conoscete solo quello, non c’è”. Infatti, appena girato l’angolo, ecco comparire appesa al muro una litografia dell‘Urlo del 1895. Inutile dire che tutte le persone se ne stavano ammassate davanti al televisore oppure in un’altra fantastica sala, una stanza di specchi con uno schermo al Led gigante (il tutto sempre tra soporifere note di pianoforte concilianti) sul quale vengono trasmessi giochi di luci e colori. Perfetto per un Reel su Instagram.
E allora quello che ci si chiede è: perché? Perché si devono allestire delle mostre in questo modo? Manco fossero per bambini… Perché viene fatta passare per una grande retrospettiva di Munch quando non lo è? Per chi sono fatte veramente queste mostre? Perché i critici, e i giornalisti, e gli scrittori tacciono e ormai sembrano come quei genitori che vanno a picchiare i professori anziché prendersela con il proprio figlio che non studia?
Qualche settimana fa ho partecipato a un incontro alla Pinacoteca di Brera in cui si parlava della condizione dei musei in Italia, durante la presentazione del libro Museologia del presente. Musei sostenibili e inclusivi si diventa. I vari ospiti, tra cui il Direttore di Palazzo Reale, Domenico Piraina, in qualche modo ci hanno risposto: le mostre, oggi, devono attirare gente, i musei devono diventare luoghi dove divertirsi, intrattenersi, al passo con i tempi. Non più luoghi per pochi dove non venivano messe nemmeno le didascalie di fianco ai quadri perché se conosci l’opera buon per te e benvenuto altrimenti arrangiati. Perché l’arte non è mai stata democratica. Servono soldi, è necessario vendere biglietti, attirare i giovani abituati ai social, bisogna dare un’esperienza e non una mostra. Ben vengano bottoni da schiacciare, fogli da colorare, schede da sfogliare, note di pianoforte, video, e chi più ne ha più ne metta. Ma la mia domanda è: perché all’estero le cose sembrano sempre fatte meglio e le mostre sono spesso enormi e hanno sale intere separate da tutto il resto per televisori o laboratori? È il pubblico italiano a volere questo – un pubblico con il più basso tasso di lettori in Europa – o lo si sottovaluta? Perché invece di livellare tutto non si pensa a ricostruire un sano piacere per la conoscenza, per l’introspezione, per la riflessione, per entrare in contatto con i propri sentimenti e soprattutto con quelli dell’artista? L’invito – ormai esplicito – sembra essere quello non soltanto di pensare, ma anche di guardare tutti allo stesso modo.
Il silenzio è troppo disturbante, lacerante. Nel silenzio si possono trovare le risposte che cerchiamo, le verità che non ci diciamo. Le emozioni spiacevoli non servono più a niente. Che farsene, poi, della riflessione, che tanto rischia di coincidere con la follia e di farci sentire fuori contesto.
Al termine della breve mostra, poco prima del bookshop, c’è stampata sul muro una frase di Munch che dice: “Attraverso la mia arte ho cercato di spiegare a me stesso la vita e il suo significato, ma anche di aiutare gli altri a comprendere la propria”.
Di fianco a questa scritta c’è una foto di Munch che ci guarda dritto negli occhi.
L’ho guardato, l’ho scrutato, e l’ho ringraziato.
E poi entri nel bookshop e trovi la rana Kermit sul poster dell’Urlo, i portachiavi, e pure un tabellone gigante con stampato sopra L’Urlo, con un buco sulla faccia, dietro al quale, ovviamente, ci si può fare la foto.
So che è giusto che sia anche così, so che i musei non sono cattedrali moderne (o forse sì) e che bastano le vere cattedrali a rimanere vuote. So che in questo paese non posso pretendere di vedere una mostra come quella di Rothko a Parigi alla Fondation Louis Vuitton, dalla quale si esce dopo almeno mezza giornata sfiniti, inebriati, emozionati, che neanche dopo una scopata, che neanche il giorno del proprio matrimonio. So che sarebbe impossibile proporre una mostra di Munch come quella di quarant’anni fa, proprio a Palazzo Reale, curata da Gianfranco Bruno e Guido Ballo, una vera e puntuale retrospettiva che rivelò l’incanto dell’angoscia, Munch e il suo dolore, senza sotterfugi. E sì, c’era anche L’Urlo (1893). Oggi sarebbe un sogno proibito, semplicemente impensabile. Tutto si è complicato, tutto si è impoverito.
Va bene, non cambierà nulla, già lo so. Però, come in ogni democrazia, voglio almeno il diritto di lamentarmi.
Articolo scritto per la rivista culturale Pangea.news