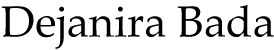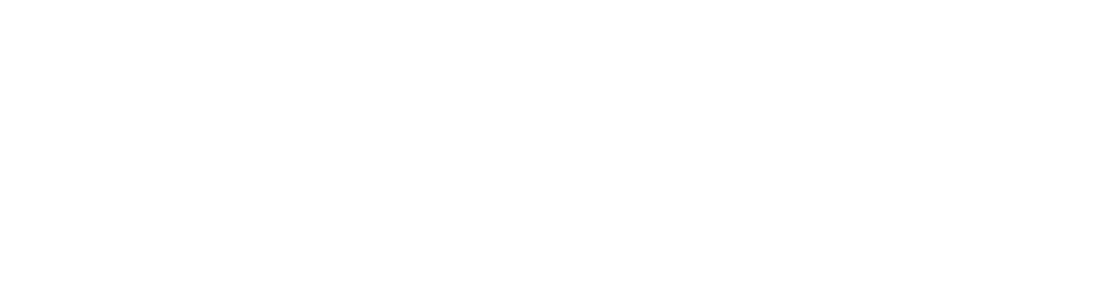La scrittura come Via. Sulle poesie del monaco Dōgen
Eihei Dōgen fu un maestro Zen (1200-1253), ma non un maestro qualunque, perché fu uno dei più importanti pensatori del Giappone pre-moderno e un originale divulgatore della dottrina buddhista, come scrive Aldo Tollini nella prefazione del libro “Eihei Dōgen – Poesie”. Dōgen maestro Zen, Dōgen poeta, Dōgen illuminato, Dōgen umano, innamorato della bellezza del mondo e della scrittura.
Per lui l’illuminazione si poteva raggiungere soltanto senza ambire all’illuminazione, senza fine e scopo, “fare solo per il fare”. E così vivere, e scrivere.
La scrittura non per la fama, non per il successo, non per i premi, i risultati. La scrittura come Via.
Come ogni vero scrittore sa, non si scrive per diventare famosi o per passare il tempo, si scrive perché senza scrivere manca il respiro, perché la vita diventa priva di senso, perché non se ne può fare a meno. La scrittura come urgenza.
Dōgen è un monaco ma anche un poeta, e sa che la scrittura può rivelarsi per lui una forma di attaccamento al mondo materiale che dovrebbe invece abbandonare, ma se la scrittura diventa meditazione, se la poesia diventa un cammino per l’illuminazione, se può servire ai discepoli per comprendere la vacuità e l’impermanenza, allora la scrittura è permessa anche a un monaco.
“In primavera i fiori
in estate il cuculo e
in autunno la luna.
Nel freddo inverno
la neve chiara e pura.”
D’altronde si crede che anche la meditazione consista soltanto nella pratica formale, nelle ore trascorse seduti sul proprio cuscino a gambe incrociate. Ma la meditazione è vivere consapevolmente nel mondo, è essere presenti in ogni istante, è lavarsi i denti con consapevolezza e presenza mentale, essere presenti quando si fa l’amore, quando si cucina, si lavano i piatti, si cammina, si defeca. È essere.
“La pratica è già illuminazione, l’illuminazione è senza limiti, e poiché l’illuminazione è pratica, la pratica non ha un inizio. La pratica quindi non ha nessuno scopo, se non quello di praticare.” Scrive Tollini. Perché la meditazione, che si pratichi in modo laico oppure no, non ha un momento in cui comincia e uno in cui finisce. La pratica è la vita e la vita è la pratica.
Dōgen cerca di liberarci dal concetto egoistico del “dare per poi avere”. Perché non c’è solo il bianco o il nero, il bene o il male, il positivo o il negativo, il vantaggioso o lo svantaggioso.
La realtà l’abbiamo ingabbiata noi. Noi abbiamo dato un nome a ogni cosa nella perversa illusione di poter definire il mondo. L’illusione di cui parla l’Oriente sta proprio in questo, nel credere che con il linguaggio l’uomo possa spiegare le cose e addirittura Dio.
La pratica, invece, che si manifesta nel silenzio, toglie alla mente ogni possibilità di determinazione. Con la calma, in pausa dal pensiero discorsivo (ovvero con la mente concentrata sul respiro o in totale assorbimento) compare la chiarezza del tutto, come in una poesia.
È inutile accatastare sapere, conoscenza, nozioni. Questo non permetterà di risvegliarsi ma solo di diventare dotti. Tollini ci ricorda che la strada è sempre quella del “conosci te stesso” occidentale, ma nel buddhismo si deve giungere a comprendere che l’Io è insostanziale, illusione, impermanente, quindi non è uno strumento affidabile per la comprensione della realtà. Quindi bisogna “dimenticare se stessi”.
Compreso ciò, che senso ha continuare a possedere se nulla ha valore e non esiste? Bisogna lasciar andare senza rimpianti. Ed è quello che Dōgen cerca di trasmetterci con la poesia. Nonostante anche lui venga ammaliato dai colori della natura, dalla sua magnificenza, i versi descrivono un mondo che in realtà non è altro che un fenomeno della nostra mente, dove nulla esiste in maniera intrinseca ma solo in correlazione a qualcos’altro. Ciò non vuol dire che la realtà che vediamo non esiste ma che esiste solo in funzione della coproduzione condizionata, la comprensione ultima che tutto è vacuità, che cerca di spiegarci il famoso monaco vietnamita Thích Nhất Hạnh in Essere Pace:
“Un poeta, guardando questa pagina, si accorge subito che dentro c’è una nuvola. Senza la nuvola, non c’è pioggia; senza pioggia, gli alberi non crescono; e senza alberi, non possiamo fare la carta. La nuvola è indispensabile all’esistenza della carta. Se c’è questo foglio di carta, è perché c’è anche la nuvola. Possiamo allora dire che la nuvola e la carta inter-sono. […] Guardando più in profondità in questa pagina, vedremo anche brillare la luce del sole […]. Se guardiamo ancora più in profondità, vedremo nel foglio anche noi. Non è difficile capirlo: quando guardiamo un foglio di carta, il foglio è un elemento della nostra percezione […]. Nel foglio di carta è presente ogni cosa: il tempo, lo spazio, la terra, la pioggia, i minerali del terreno, la luce del sole, la nuvola, il fiume, il calore. Ogni cosa coesiste in questo foglio. “Essere” è in realtà inter-essere.”
E all’origine il vuoto.
Una volta capito questo, ecco l’illuminazione, la liberazione, il satori, il mokṣa, il nirvanā, l’estinzione, la pace assoluta dopo la morte, senza più rinascita e sofferenza.
Ma per comprendere, spesso non basta una vita, per chi ci crede. Ci vogliono infinite rinascite. E bisogna sperare di aver condotto una retta vita e reincarnarsi nel corpo di un essere umano, non in quello di un animale, perché solo con la nostra mente ci si può risvegliare.
Tollini ci spiega che l’illuminazione non si ottiene, si attua. Non è averla ma esserla. E l’illuminazione non permane, ma è come una lampadina che si accende e si spegne, si estingue e ricompare. Si deve essere momento per momento, non si acquisisce.
Il vero dilemma dell’uomo si manifesta nello zazen, quello di Dōgen ha il nome di shikantaza, “sedersi solo per sedersi”, dove il confronto avviene con se stessi, dove il senso della pratica si rivela: la ricerca del proprio essere originario oltre il velo delle illusioni. Dove si diventa le cose, non si percepiscono soltanto.
“La luna si riflette
nell’acqua limpida
del mio cuore.
Anche le onde si calmano,
e tutto splende.”
Arrivati fin qui, ci rendiamo conto della difficoltà di tali concetti. Nella scuola Zen Rinzai si fa largo uso dei kōan, affermazioni paradossali utili nella pratica meditativa per raggiungere intuizioni profonde e quindi il risveglio spirituale. Nella scuola Zen Sōtō di Dōgen, i kōan furono invece abbandonati e si proseguì soltanto con la shikantaza. Ma Eihei, anche con la sua poesia, cerca di indicare la Via, di essere d’aiuto per i discepoli e perché in fondo non riesce a fare a meno di scrivere.
In Giappone l’arte, la pittura, la musica e la poesia, sono la pratica, sono la Via, inscindibili; rivolgono lo sguardo alla morte, al dopo, e quindi, come la meditazione, sono anche capaci di purificare la mente e il cuore se si pratica con kokoro puro.
“Dunque, sempre, camminando, stando fermi, sedendo e giacendo il kokoro (cuore-mente) sia volto alla poesia”, come scrive Murato Yayoi.
Una pace, un cammino, che si trova nella purezza della natura senza contaminazioni, al centro di ogni concezione religiosa in Giappone. Perché la natura è così com’è, spontanea, senza corruzioni, è già illuminata, noi possiamo soltanto prendere esempio da lei.
“Tra le profonde montagne,
sui picchi e nelle vallate,
manda il suo canto la cicala
per dirci che
il giorno è terminato.”
Per Dōgen anche gli esseri inanimati hanno la natura di Buddha e sono illuminati. La natura priva di mente è il vero aspetto della realtà. L’erba, gli alberi e la terra sono la mente, e quindi sono esseri senzienti, che comunicano però in una lingua a noi non udibile. Noi usiamo la parola, la natura una lingua che può essere udita soltanto da chi cerca la Via.
Come scriveva anche San Bernardo di Chiaravalle: “Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà.”
E anche se la natura, l’arte e la poesia generano attaccamento, bisogna ricordare che per perseguire la Via ci vuole passione, impegnarsi con tutto se stessi pur non sperando di ottenere alcunché. Si deve sentire e avere cuore e passione per raggiungere la liberazione “Chi pensa di essere distaccato per giungere al distacco sbaglia e non giunge da nessuna parte.”
Come gli Shivaiti tantrici del Kashmir in India (VIII-X secolo), che superarono il concetto prosaico di ascetismo e rinuncia indicando una nuova Via, quella del tuffarsi in ogni emozione fino in fondo, nel piacere e nel dolore, con presenza e consapevolezza. Dal Vijñānabhairava, la conoscenza del tremendo:
“All’inizio e alla fine di uno starnuto, nella paura, nel dolore o davanti a un precipizio, nella fuga da una battaglia, nell’eccitazione del desiderio, all’inizio e alla fine della fame, è presente l’essere del brahman.”
“Lo yogin fermi la mente dovunque essa trovi appagamento. Ecco che lì si invera la natura della beatitudine suprema.”
“Allo sperimentare una grande gioia o alla vista di un amico dopo lungo tempo, meditando sulla beatitudine sorta, lo yogin immerso con la mente in essa si dissolve.”
“La natura divina che lo yogin raggiunge non è qualcosa che prima non fosse, ma null’altro che la sua stessa intima natura di cui egli era soltanto incapace di prendere coscienza, benché fosse manifesta, per colpa delle costruzioni mentali suscitate dalla potenza di Maya.”
E lo stesso vale per la natura di Buddha, che è già nel monaco, nel discepolo, in ogni essere umano. Senza sforzo, si capisce che cerchiamo sempre qualcosa al di fuori, quando tutto è già ed è sempre stato dentro, lì, nell’attimo presente, senza passato né futuro, rappresentazione dell’Assoluto o della Vacuità. L’intuizione è fugace ma se si manifesta, lo fa nel qui e ora, in quell’adesso che si svela davanti ai nostri occhi e che non possiamo spiegare con le parole. Lì c’è il Tutto.
Sempre Dōgen:
“Tutto il cielo e l’intero cielo
e poi non rimangono parole.”
La vita è saper provare gratitudine per quell’attimo, anche se a parole non sappiamo dire perché e che cos’è. Bisogna abbandonare i discorsi, ogni testo scritto e tutto quello che si è imparato fino a quel momento, perché non è altro che ignoranza e arroganza di aver creduto di comprendere qualcosa con il pensiero.
Torella continua: “Attraverso l’esperienza di stati d’animo, sensazioni ecc., spinti al limite estremo, lo yogin può attingere la realtà dello spanda, l’energia vibrante indifferenziata, la realtà assolutamente ultima di tutto ciò che esiste. L’ira, la gioia, il dubbio, la fuga disperata di fronte a un pericolo provocano, giunte alla massima intensità, una sorta di vuoto nella coscienza, espellendo tutta la molteplicità inestricabile e fluttuante dei vari stati mentali. A questo punto, lo yogin che è sempre rimasto presente a se stesso acquieta improvvisamente il dubbio o l’ira, compiendo quel movimento che fa la tartaruga quando ritira di scatto tutte le membra; oppure, nel caso della gioia o del terrore, li fa dilagare. È in questo momento che lo yogin, seppure per un attimo, tocca nel vivo in tutta la sua purezza e violenza, il proprio principio nascosto.”
Dal Vijñānabhairava
“…colui che ha conseguito questo stato di coscienza, vedendo il mondo intero come gioco, ininterrottamente compenetrato con la suprema realtà, è senza dubbio un liberato in vita.”
Dall’India al Tibet al Giappone, appare chiaro che anche dopo aver raggiunto l’illuminazione (proprio come insegna anche la scuola del buddhismo Mahāyāna a differenza di quello Theravāda), si deve tornare nel mondo degli esseri senzienti, cioè tornare a vivere e a partecipare alle cose del mondo come gli esseri ordinari, ma con una diversa consapevolezza: “la grande illuminazione non svanisce”, e quindi non si torna a essere “persone ordinarie”.
Si torna nel mondo per aiutare tutti gli esseri umani a intraprendere la Via e permettere così anche a loro di raggiungere l’illuminazione e liberarsi per sempre dal ciclo delle reincarnazioni. Ma per farlo bisogna sporcarsi con la polvere del mondo, farne parte e provare le stesse sensazioni e sentimenti della gente comune.
E così dopo la rivelazione si continua a osservare la natura, a vivere, a provare gioie e dolori ma probabilmente in modo diverso, con maggiore saggezza, senza farsi turbare troppo dai fenomeni dell’esistenza, consapevoli della loro inconsistenza e caducità.
“Nella mia capanna di paglia,
sia quando sto in piedi sia quando sono seduto,
prego affinché
prima di me,
gli esseri siano portati oltre.”
La gioia di vedere un fiore rimane gioia di vedere un fiore, pur consapevoli che i petali cadranno e che il fiore appassirà. Il ciclo della vita sarà visto come naturale e non causa di dolore. Non ci affidiamo più alla mente quando capiamo che non ha sostanza.
Una mente acquietata vede un mondo di pace e di serenità in tutte le cose.
La paura della morte è vinta. Si torna a casa, al luogo di partenza.
Il tempo è poco per capirlo, non va sprecato.
La quotidianità come grandiosa illuminazione.
Articolo tratto da Pangea
“Il kokoro sia volto alla poesia”: la scrittura come pratica e Via